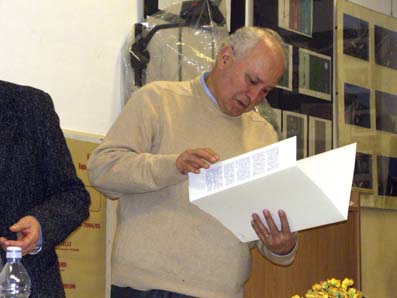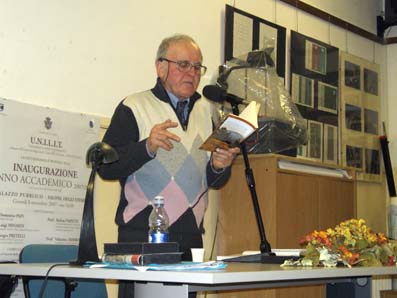|
MARZO 2008 Giovedì 6 Ore 16.00
Prof. Gastone Mosci
Presentazione del libro “Racconti
Urbinati” di Alberto Calavalle Il Prof. Alberto Calavalle illustra alcune parti dei racconti
____________________________________________________________________
Alberto Calavalle racconta Urbino di Gastone Mosci
Alberto Calavalle ha pubblicato cinque libri: due di racconti (“Il tempo dei cavalli. Racconti di una sera”, Guaraldi, 1993; e “Racconti urbinati”, QuattroVenti 2007); un romanzo (“Sulla frontiera della Vertojbica”, Editoriale ECO 1997); una raccolta poetica (“Infinito passato. Poesie per Urbino”, introduzione di Gastone Mosci, QuattroVenti 2000), un libro di critica letteraria (“Finestre sulla città. Cronache urbinati, racconti, personaggi del XX secolo”, nota di Silvia Dolciami Crinella, Montescudo 2003). Calavalle pubblica con una cadenza regolare ogni tre-quattro anni. Inizia la sua avventura letteraria con il racconto, l’affabulazione, il ricordo e la ricostruzione di un’epoca, nutre una visione precisa del suo lavoro di scrittore attraverso la gente della sua città, propone una lettura della realtà urbinate. Di questa realtà numerosi, vari sono stati i lettori e gli interpreti. Paolo Volponi (1924-1994) inizia con la poesia, “Il ramarro” (Scuola del Libro 1948), dove indaga il suo mondo giovanile, l’ambiente e osserva da lontano l’Appennino (poi, “Le porte dell’Appennino”, 1960), continua con la poesia per approdare dopo più di dieci anni al romanzo “Memoriale” (1962). Va dalla poesia alla narrativa anche se la sua prima proposta di romanzo, “La strada per Roma” (1991), resta inedita quasi per tutta la vita. Anche Egidio Mengacci (1925-2000) nasce con la poesia e resta ancorato alle sue “Carte” (Scuola del Libro 1959), pur con forti interessi per la grafica con la Galleria L’Aquilone. Ercole Bellucci (1937-1997) è un “chierico” della poesia e dell’editoria d’arte già con “L’affronto della voce” (Scuola del Libro 1960). Padre Adriano Gattucci (1935), francescano, docente di storia medioevale a Urbino, ora al Beato Sante, è rimasto sempre fedele alla poesia, fin da “Appunti di viaggio” (1967). Zeno Fortini (Barchi 1939), che incontriamo sempre in piazza, si rivela subito con le canzoni di “Paura di dire” (1968). Sono ancora da segnalare don Amato Cini (1919-1987), Neuro Bonifazi (1922), Maria Lenti. Umberto Piersanti (1941) ricrea invece la piena tradizione urbinate: inizia con la poesia, passa al cinema, approda al romanzo, e riattraversa un campo sempre più complesso fin da “La breve stagione” (1967). Gli urbinati sono attratti dalla poesia, sono poeti notevoli: il cuore della ricerca è sempre Urbino, la città dell’anima, dice Carlo Bo, che ha amato e sostenuto tutti questi amici scrittori, dei quali è stato attento lettore. Urbino è dunque una città di poeti, una città aperta alla bellezza in ragione della sua tradizione e del suo paesaggio, ed anche grazie alla collaborazione dei numerosi grandi incisori della Scuola del Libro. Dopo questa rassegna, una specie di cronaca d’arte, torno all’autore di “Racconti urbinati”. Calavalle è l’autore che viene dopo quella costellazione del secondo novecento: il suo campo operativo è sempre Urbino, ogni suo libro porta un segno preciso. Egli guarda le mura della città ed i colli con uno sguardo particolare: ricrea sogni e visioni dell’infanzia, ripercorre il suo mondo contadino nutrito dalla tradizione orale, fa conoscere l’anima popolare della città, interviene con il dialetto. Vive una sua personale e misurata dimensione creativa, conserva una inquietudine segreta. Ne “Il tempo dei cavalli”, il suo primo libro, affronta la città da porta Lavagine. Lui abita al Palazzo, una villa rinascimentale vicino a San Bernardino, vive ad Oriente e scruta Urbino in due luci particolari, al mattino sotto i raggi dell’alba e nel brusio della città che si sveglia, e di sera nei grigi sempre più cupi. La sua Urbino sembra una città del silenzio, eppure cerca sempre di renderla squillante: non guarda i monumenti, l’urbanistica, racconta le persone, gli artigiani, il maniscalco, lo scalpellino, l’oste che hanno tutti un nome ed un soprannome. E racconta storie della sua infanzia, degli anni cinquanta-sessanta, Urbino d’un tempo passato, sempre con un timbro corale, quasi una storia collettiva di ragazzi che continua, che si espande nell’esperienza dei rioni. Anche “Racconti urbinati” esprime questa dimensione ma è un libro misurato sulla conoscenza con una scrittura matura, senza ombra di nostalgia. Lo scrittore vuole fare conoscere una realtà precisa per porre, in definitiva, domande nuove ed inquietanti. Dopo i racconti viene il romanzo con una storia che nasce nel borgo originario della sua famiglia, in campagna verso il Metauro, per passare in città o meglio in un luogo privilegiato d’osservazione, le colline che difendono la bellezza della città dei due colli, la sua armonia, la misura del lavoro dell’uomo, la matematica del rinascimento. La narrazione si snoda intorno alla grande guerra con notizie, sentimenti, analisi d’emozioni e di desideri. L’indagine di Calavalle ha sempre un orizzonte, è parte della letteratura della crisi: questa volta il sistema dei diritti in un drammatico evento bellico e di una calda partecipazione politico-sociale. Il libro delle liriche, “Infinito passato. Poesie per Urbino”, con una suggestiva acquaforte in copertina del fratello incisore Adriano, offre una visione inedita della città: non solo l’Urbino d’Oriente ma anche la sezione di ponente dei Cappuccini, nella controluce del tramonto, non la maestà rinascimentale dei mattoni infuocati ma la sofferenza della decadenza e della povertà. Cos’è Urbino oggi? Queste situazioni e queste domande ritornano nel suo quarto libro di una prosa, molto agile, aggiornata, vivace, piena di slanci, “Finestre sulla città”, finestre come luoghi d’osservazione di Carlo Bo, di don Italo Mancini, di Paolo Volponi: ogni finestra è un simbolo, un’icona, un progetto, Le cronache letterarie di Calavalle sono mosse dall’insegnamento di Carlo Bo, in dialogo con la sua lezione quotidiana della vita, mettendo sempre in luce i tanti personaggi che rendono viva la comunità, chi ama la città ed i suoi abitanti. Direi che si tratta di un libro con un grande spessore d’umanità e di riconoscenza. Calavalle raccoglie l’invito di Carlo Bo di continuare a porre domande impegnative sull’oggi con l’impegno di tenere fede ad un umanesimo autentico. Nei suoi libri il nostro amico parla sempre di Urbino, gli altri scrittori urbinati d’oggi parlano di sé e in sottordine di Urbino. Quali altre voci di cultura militante possiamo ascoltare su Urbino? Forse poche, svelte, atone, senza nervatura, a parte Ilvo Diamanti con gli editoriali su “Repubblica”, in modo sistematico, da sociologo, da docente universitario: all’interno della sua rubrica, “Mappe”. Diamanti, per fare un solo esempio, attraverso il suo giornale ha salvato l’ateneo urbinate dal disastro: ora la statalizzazione permette di riaprire un discorso promozionale nuovo. E Calavalle? Compie la stessa opera di persuasione dal suo osservatorio, rappresentato dai suoi libri, uno ogni tre-quattro anni, e dal settimanale “Il nuovo amico”, al quale collabora. Il suo lavoro di scrittore non ha ancora molta efficacia civile perché i suoi strumenti della comunicazione sono limitati, ma la sua testimonianza è valida. Ecco dunque la conclusione: Alberto Calavalle è un autore che vive intensamente la città, è pronto ad intervenire, è disponibile al confronto. La sua pagina, racconto o poesia o cronaca, è una sfida coraggiosa. Va ascoltato in questa disponibilità di scrittura, in questa dimensione di letteratura e vita, nella consapevolezza del primato dello spirituale: non dà niente ad intendere, è uno scrittore autentico.
Carlo Bo: Urbino, la città dell’anima di Gastone Mosci
“Per capire Urbino non basta una vita”, lo dice Carlo Bo in apertura di un suo libro speciale, “Parole sulla città dell’anima”, a cura di Gilberto Santini (Urbino 1997), un vero e proprio livre de chevet, che invita a dodici letture per entrare nello spirito di una “città dell’anima”. Questo aforisma suggella la chiusura di un’opera che rappresenta una riflessione sulla bellezza e sulla spiritualità della città. I testi di Carlo Bo vanno dal 1959 - il giorno della sua cittadinanza onoraria urbinate - al 1997, durante i suoi cinquant’anni di rettorato. L’opera ha un valore di testimonianza culturale ma anche di itinerario di civiltà e di spiritualità. In questo testo Carlo Bo si pone di fronte all’immagine della città, nell’intento di leggerla e di interpretarla: cercare di capire vuol dire entrare prima nello spirito della città, della gente, poi nell’ordine della storia; “qui batte il cuore dell’Italia, c’è qualcosa che miracolosamente è stato realizzato nei secoli passati e che adesso è riassumibile, è simboleggiato dal Palazzo Ducale”. La città dell’anima passa attraverso la centralità del Palazzo Ducale, “che è un’idea d’arte, un’idea di bellezza, di poesia”. Ecco dunque una lettura, come sogno diurno, per comprendere il senso di questa città, relegata a isola, a mondo separato, e quindi saltata dalla storia, ma difesa nella sua essenza da un progetto misterioso, come le Marche “isola di poesia nel cuore dell’Italia”. Questa città dell’anima vive in un sistema di “isolamento” che la definisce, ma che diventa anche “piccolo osservatorio” di ciò che accade nell’ambito nazionale: “stando così separati, così distanti, così arroccati su un colle, uno che ci viva, che ci sia nato, che abbia passato qui la sua vita e che sia stato dotato di capacità poetiche – per esempio Volponi – ecco che un individuo di questa specie è in grado di andare al di là della storia e di vedere quello che si sarebbe potuto fare, quello che si è fatto, quello che si è perduto nei secoli e quello che, nonostante tutto, permane, resiste, respira”. Ma non basta, la città non è solo il Palazzo Ducale ma un luogo che si arricchisce “nella bellezza del paesaggio, delle colline, di questa luce stupenda che c’è nei giorni più limpidi, più chiari”. La città vive, poi, una specie di magia, che è nutrita dal tempo, non solo “una città del silenzio” ma una “dimora delle Muse”, una casa accogliente, il “simbolo del Rinascimento e della vittoria dell’Umanesimo”. “In fondo Urbino è un’invenzione poetica, della natura, del Creatore e di quello che in passato hanno saputo fare i grandi artisti che qui hanno lavorato, che hanno vissuto la città…” Piero della Francesca, Francesco di Giorgio Martini, il Castiglione, ma anche gli umili artigiani e costruttori che hanno rispettato l’architettura ed il paesaggio. Ancora un dato cui Bo tiene molto: una città dell’anima è una “eredità ideale”, è una grazia ricevuta per chi è del luogo: per chi giunge a Urbino sembra un miracolo, per chi vi è nato è un “dono quotidiano, naturale”. Nell’orizzonte di Carlo Bo la città dell’anima non è solo espressione di ricchezza artistica e storica ma anche la città universitaria: nel suo insieme Urbino educa lui stesso sul piano umano, gli organizza una “buona intelligenza della vita”. E quindi il rapporto con la cultura, con lo studio si trasferisce al dialogo con i colleghi, il personale non docente, i cittadini, ma soprattutto gli studenti che sono il cuore dell’ateneo: la scuola è in rapporto con la vita, come la cultura che è parte integrante del sistema umanistico. Gli studenti stessi, che sono più degli abitanti, contribuiscono a creare una città tutta particolare, a rappresentare una “sorgente viva”, a stabilire un’alleanza fra una città d’arte ed una popolazione di giovani, che esprime il senso della vita. Ma quale Università? Una Università come scuola particolare, con l’idea di libertà e con il sostegno dei diritti dell’uomo; una cultura “come segno della continuità e di una speranza che possa vincere lo spettro della morte”. In uno degli interventi, Carlo Bo pone un’altra domanda prediletta: “Siete mai venuti a Urbino?” E continua: “Se continuerete a rispondere di no, dovrete sentirvi in colpa, perché vi mancherà una dimensione della civiltà italiana”. La questione nasce nel 1965, quando interviene per sostenere una legge speciale del parlamento a favore di Urbino, che crolla. Lancia un grido d’allarme e porge un invito per scoprire Urbino e la bellezza del suo territorio: “Urbino è un paesaggio incantato”, perché è rimasto intatto ancor oggi. Questo volumetto, “Parole sulla città dell’anima” (1997), rivolto principalmente all’idea di città, come l’ha maturata interiormente e come l’ha veduta e vissuta, fin dal suo arrivo nell’ottobre 1938, sotto il segno del Palazzo Ducale, è un’anticipazione dell’opera maggiore, che comprende anche i volti di Urbino e delle Marche, i poeti e gli scrittori, gli amici ed i testimoni di una civiltà dello spirito: “Città dell’anima. Scritti sulle Marche e i marchigiani”, a cura di Ursula Vogt, che esce postuma nel novembre 2001. Il mio intervento è rimasto circoscritto a Urbino, affascinato da “Una visione libera e aperta”, suggestiva e feconda idea da cui muovono l’invenzione e la creazione del Palazzo Ducale, ma anche modello di un nuovo umanesimo con le voci della pace, della musica e della poesia, in una città dello spirito, che tiene vibrante la forma dell’utopia.
per rivedere sunti ed immagini del programma svolto, entrare nella pagina di Cagli e da qui nella sezione calendario-programma, quindi cliccare sul nome del relatore.
|