|
Francesco Pucci, battezzato dal curato della Cattedrale don
Alessandro Blasi il 3 dicembre 1817, era figlio di Feliciano di
Vincenzo fu Girolamo Pucci e di Anna fu Sante Santarelli.
Della prima formazione di questo maestro cagliese poco è dato
sapere, anche se è logico supporre un iniziale tirocinio in
qualche bottega artigiana e forse in quella che appartenne a
Vincenzo Pucci visto che il nome di quest'ultimo, probabilmente
il nonno di Francesco, figura per taluni lavori di falegnameria
commissionati tra la fine del Settecento e i primi anni
dell'Ottocento dai conventuali di San Francesco di Cagli.
Nella formazione di Francesco Pucci si inserisce un ulteriore
elemento che dovette servirgli certo per affinare le conoscenze
e per mettere a maggior profitto i segreti di ottega già
appresi.
Nel
1850 grazie in particolare all'impegno dell'architetto
Michelangelo Boni, allievo del Valadier,
 il
Comune di Cagli con la nomina di Belisario Simonelli da Perugia
avrebbe dato vita alla prima scuola locale a indirizzo artistico
professionale. La Scuola di Disegno di Cagli, che per l'anno
scolastico 1868-69 era munita di un ordinamento didattico
articolato in “1) Ornato e Figura; 2) Architettura e
Prospettiva; 3) Ornato in Plastica e Scultura", si sarebbe
trasformata nel 1881 nella "Scuola serale e domenicale di arte
applicata all'industria" (dedicata nel 1906 a Gaetano Lapis)
onde fornire "in un corso di tre anni l'insegnamento del disegno
con applicazioni ai lavori di ebanista, falegname, scalpellino,
muratore, fabbro ferraio, vasaio". I quaranta iscritti nel 1883
erano ancora per la maggior parte studenti lavoratori. il
Comune di Cagli con la nomina di Belisario Simonelli da Perugia
avrebbe dato vita alla prima scuola locale a indirizzo artistico
professionale. La Scuola di Disegno di Cagli, che per l'anno
scolastico 1868-69 era munita di un ordinamento didattico
articolato in “1) Ornato e Figura; 2) Architettura e
Prospettiva; 3) Ornato in Plastica e Scultura", si sarebbe
trasformata nel 1881 nella "Scuola serale e domenicale di arte
applicata all'industria" (dedicata nel 1906 a Gaetano Lapis)
onde fornire "in un corso di tre anni l'insegnamento del disegno
con applicazioni ai lavori di ebanista, falegname, scalpellino,
muratore, fabbro ferraio, vasaio". I quaranta iscritti nel 1883
erano ancora per la maggior parte studenti lavoratori.
Coro di S. Croce a Fonte Avellana
La
Scuola di Disegno comunale, che va intesa come un potente
strumento per il superamento delle carenze nell'insegnamento del
disegno e per una più adeguata organizzazione della formazione
del settore dell'artigianato artistico, nel periodo in cui fu
direttore Belisario Simonelli (1850-1864) annotò tra i suoi
allievi anche Francesco Pucci e Mattia Garavini (Russomanno,
1942).
Dunque era più che trentenne quando, verosimilmente nei
primissimi anni Cinquanta del XIX secolo, si iscrisse alla
Scuola di Disegno.
Il
tirocinio presso un laboratorio artigiano doveva averlo
probabilmente già concluso poiché lo si ritrova nel 1853 a capo
della propria bottega. La notizia si ricava da una delibera
consiliare del 12 febbraio 1857 che pur trattando di una
questione alquanto insignificante, fornisce utili informazioni.
Nel processo verbale è dato leggere che "Francesco Pucci
Ebanista in questa Città fin dal 1853 per dar lavoro ai suoi
Garzoni costruì alcune finestre per le scale di questo pubblico
Palazzo di che ne era mancante".
Tavolo urbinate
Il
Pucci aveva molteplici esempi di opere intagliate con cui
confrontarsi, in Cagli, di artefici del XVII e XIII secolo
provenienti da varie città.
Come
nella chiesa di Sant' Andrea degli Zoccolanti dove al coro di
fra Giacomo da Pesaro si affiancano confessionali, pulpito e
panche di un certo livello qualitativo. E il refettorio delle
monache domenicane di San Nicolò con i postergali de' seditoi,
le Porte, la Cattedra ove si sta a leggere nel Refettorio, le
finestre, le grate delle gelosie della chiesa, il coro inferiore
dello stesso monastero, il monumentale trono dorato della statua
della Madonna del Carmine.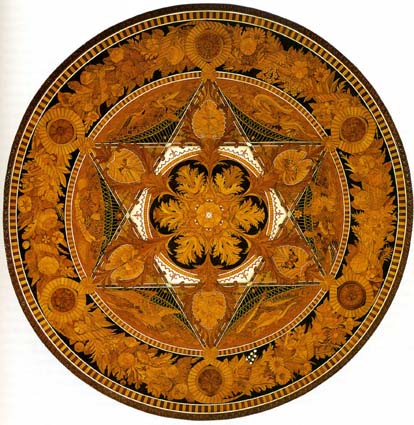
Un
Sabbatini falegname aveva completato l'ampio coro di noce della
Cattedrale cagliese, dopo che Mastro Carlo da Fossombrone
intagliatore e Mastro Bonaventura Monti falegname d'Urbania
avevano già realizzato i primi sedici stalli e la "Sedia
Episcopale, che è nel mezzo".
Un
altro Sabbatini, e precisamente mastro Domenico Sabbatini aveva
realizzato per la chiesa dei francescani conventuali di Cagli
una "Croce di Legno con sua asta" e "una muta di Cartaglorie per
l'Altare di Sant'Antonio", entrambe assegnate al Sig. Ferri
della Pergola per l'argentatura.
Tavolo viennese
E gli
apparati lignei laterali della chiesa di San Bartolomeo, del
cagliese mastro Bonifacio Tornari sul tema dell’altare
maggiore ligneo ideato da Benedetto Ginestra da Fossombrone,
artefice anche del prezioso soffitto a cassettoni per la
copertura dell'intera aula, in seguito dorato da mastro Tommaso
Vannucci da Fossombrone.
Ancora del Ginestra, in Cagli, l'ornato ligneo del terzo altare
laterale destro nella chiesa di San Francesco.
Occorre, poi, spostarsi nei palazzi gentilizi per ritrovare in
rari spazi quattro-cinquecenteschi, che non hanno subito
posteriori alterazioni, soffitti lignei a cassettoni come quelli
di palazzo Tiranni-Carpegna (palese omaggio cortigiano ai duchi
d'Urbino), o quello dell'androne del quattrocentesco palazzo
Preziosi-Brancaleoni.
Nel
mondo dei maestri di legname cagliesi spicca nel XVI sec. "Magister
Nicholaus Ant. Ludovici de Callio", realizzatore per i monaci
benedettini della basilica di San Pietro in Perugia venti quadri
del coro del presbiterio oltre a due ulteriori quadri dallo
stesso maestro calliense lavorati in Perugia.
A
Cagli però, come in tanta parte delle Marche, sono alquanto rare
le opere intarsiate.
Il
giudizio non può che essere frammentario, considerato che
risulta pressoché impossibile conoscere il ricco patrimonio
presente nelle numerose dimore patrizie essendo andato quasi
completamente disperso nella seconda metà del Novecento.
Per
tale motivo merita di essere menzionato il complesso tabernacolo
seicentesco della chiesa del convento dei Padri Cappuccini che,
per il suo disegno architettonico e per la tarsia con inserti in
osso e madreperla, molto ricorda quello di fra Giuseppe da
Patrignone eseguito per il convento dei Cappuccini di Camerino.
Frutto di queste conoscenze fu quindi l’opera del Pucci.
I
Camaldolesi gli affidarono nel 1853 la realizzazione del nuovo
coro del monastero di Fonte Avellana.
Lo
eseguì su disegno del professore Belisario Simonelli portando
come collaboratore l'allievo Mattia Garavini.
Nel
1856, in Urbino, nella rinnovata Sinagoga, portò a termine i
lavori commissionatigli per questo Tempio Israelitico: oltre
l'arca e il pulpito, anche le balaustrate lignee intagliate dei
matronei, la scala delle donne, nonché le cinque panche di noce
tuttora presenti nel tempio.
L'edificazione del nuovo Teatro Comunale di Cagli,
concretamente avviata nel 1871, vede particolarmente impegnato
Francesco Pucci.
Ottenutane la "Direzione dei lavori da falegname nella
costruzione del nuovo teatro", lavorò a fianco di Alessandro
Venanzi, che è definito come "Direttore dei lavori di
decorazione”.
Al
Pucci va senza dubbio grande merito nella la realizzazione dalla
lumiera: "visto il nuovo disegno della lumiera a scheletro
redatto dal Prof. Venanzi la Giunta lo approva, ed incarica
l'ebanista Pucci Francesco di questa Città per la costruzione”.
Il lavoro della lumiera è, però, dal Tarducci attribuito a
Rinaldo Paioncini allievo e capace intagliatore allora presente
nella bottega del Pucci. Va notato però come l'analisi del
progetto della lumiera, conservato nel Museo del Teatro Comunale
di Cagli, permetta di rilevare talune varianti che furono
apportate dal Pucci durante la realizzazione.
Nel
1876, il Pucci, che non doveva essersi minimamente risparmiato
nel suo incarico, era nominato "Custode provvisorio del nuovo
Teatro"
Del
1877 è la realizzazione del "mobiglio dei palchi al nuovo
Teatro", identificabile con gli attuali sgabelli di legno di
faggio.
Sono
del Pucci le sedie in noce chiaro, con la spalliera imbottita in
velluto, ancor oggi impiegate per la sala consiliare, e il
tavolo.
Delle tante realizzazioni del Pucci ebanista e intarsiatore
rivolte alla committenza privata rimane solo una troppo generica
indicazione nell'opera del Tarducci, il quale nei primi anni del
Novecento poteva affermare che "in più famiglie se ne conservano
assai belle scrivanie e stipi e altri lavori di vario genere" (Tarducci,
1909).
Possiamo citare ad esempio il Tavolo viennese, certamente
l'opera di maggiore rilievo di Pucci, che fu trattenuto
dall'artista fino al 1881 anno in cui volle cederlo al Comune
non solo per motivi economici, considerato che è lo stesso Pucci
nella lettera di quell'anno ad esprimere il desiderio che
"rimanesse qual mia memoria in questa nostra città, e parmi che
potrebbe essere ornamento non indegno del pubblico palazzo”
Il
Tavolo urbinate, databile all'anno 1867, concesso dalle sorelle
Centanni al Comune di Cagli qualche decennio fa.
L’elegante scrivania da centro posta nel Gabinetto del Sindaco
di Cagli e la poltroncina.
All'interno del Palazzo Pubblico è anche una scrivania da centro
in radica con cassettiere e l'elegante scrittoio con alzata.
Il
bancone della Farmacia Berardi a Cagli, tradizionalmente
assegnato a Francesco Pucci
In
Pesaro, già presso l'ing. Enrico Mochi, un tavolino con piano
ottagonale.
Tre
tarsie a motivi floreali e l'elaborato portagioie a bauletto
presso privati in Cagli.
Nel
1881 viene affrontata dal consiglio comunale la questione
dell'acquisto di "un tavolo a tarsia ed intagli col
corrispettivo di una piccola vitalizia pensione", votata a
consenso unanime. Nella lettera, trascritta nel processo verbale
della riunione in modo da diventarne parte integrante, Pucci
afferma che la pensione richiesta pari a £ 400 annue "non
sembrami possa stimarsi gravosa, se si consideri l'età mia di 63
anni compiuti, e la cattiva salute". I consiglieri, che
fissarono in £ 360 la rendita annua vitalizia, quando nelle
sopracitate delibere degli anni 1885 e 1886 esaminarono la
questione dei mobili dell'ebanista intarsiatore per la sala
consiliare, avrebbero più volte fatto riferimento "alla sua
deplorevole condizione", allo "stato infelice in cui al presente
si trova" e ancora alla "lunga e penosa malattia" che lo ha e
ridotto "a miserevole condizione.
La morte del Pucci
sopravvenne il 26 novembre 1886
Ottenne "un posto
distinto al Civico Cimitero per tumulare la salma del defunto
Pucci Francesco, ebanista che ha fatto onore al paese".
Nella lapide posta
nel Cimitero di Cagli che reca, a bassorilievo, uniti da un
nastro, gli attrezzi dell'ebanista, sono rimarcati anche i
riferimenti al patriottismo, alle capacità professionali e alla
stima dei contemporanei.
Il riferimento come
buon patriota dovrebbe riguardare la partecipazione di Pucci,
quale volontario con qualifica di sergente, alla difesa di
Ancona durante l'assedio del 1849.
L'atteggiamento del
giovane Pucci, tanto lodato dopo l'Unità d'Italia, non era
invece piaciuto in passato all'autorità del destituito Stato
Pontificio, poiché nell'elenco degli individui schedati dalla
curia vescovile di Cagli figura il nome di Francesco Pucci.
La felice stagione
ottocentesca cagliese dell'intarsio vissuta con il Pucci, non si
sarebbe così ripetuta, svanendo ben presto con il maestro i
segreti più inaccessibili di quest'arte e la profonda conoscenza
della tecnica che permisero di realizzare anche quelle
particolari coloriture che sono una delle peculiarità delle
opere dell'ebanista cagliese, di colui che va certo annoverato
tra i più interessanti e capaci artefici marchigiani
dell'Ottocento.
Dott. Alberto M;azzacchera
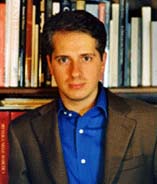 |