|
DICEMBRE 2007 Lunedì 03 Ore 16.00 Dott. Salvatore Frigerio
CORPOREITA' / SESSUALITA' NELLA TRADIZIONE
GIUDAICO-CRISTIANA |
|
Il valore dell'esistenza e quindi della
corporeità intese come atto d'amore fecondo dell'Elohim e come tempo e
spazio in cui si realizza l'unicità del rapporto che lega Dio all'adam,
percorre tutta la Scrittura giudaico-cristiana. In essa
Ma nei testi biblici la corporeità assume anche valori simbolici. Sono numerosi gli esempi in cui la fisicità e le sue dinamiche vengono lette sorprendentemente quali metafore del rapporto tra Dio e I'adam. Si pensi a Geremia: il profeta viene chiamato al suo compito con modalità che richiamano quelli dell'innamoramento: Il Santo non solo incoraggia il ragazzo a parole dicendogli "ecco ti metterò le mie parole sulla bocca ", ma stende anche la mano e gli sfiora la bocca. Nei successivi frangenti Geremia si sente tradito dal Santo e dalle sue promesse, e nasce un linguaggio che fa riferimento ali' esperienza di un amante deluso e abbandonato, quasi a sottolineare la visceralità non solo simbolica del suo rapporto con Dio. " Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto violenza e hai prevalso " (Ger 20,7), e continua con versetti brucianti di passione e di rabbia, con parole che denunciano un tremendo malessere emotivo, comprensibile solo da chi ha provato la bruciante esperienza d'essere tradito e abbandonato da chi si ama: "Mi dicevo: Non penserò più a Lui, non parlerò più in suo nome! Ma nel mio cuore c 'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie os.\'a; mi .s:forzavo di contenerlo, ma non potevo " (Ger 20,9). Geremia vive la bruciante sensazione di aver perduto la dimensione di compiutezza che solo la relazione con Dio gli donava: è un sentirsi separato, abbandonato, rifiutato, non più coinvolto nella esperienza unificante del rapporto con Dio, e proprio il corpo ospita il dolore lancinante del rifiuto. Anche Dio sceglie la via del linguaggio corporeo e delle emozioni, per comunicare con l'adam, finendo con il dare un fondamento profondo a tali modalità di comunicazione e a tali sentimenti. (Il Secondo Testamento radicalizzerà tutto questo con l'incarnazione del Verbo stesso). L' Alleanza è espressa con il segno delle Nozze di cui il Santo è lo Sposo e Israele la Sposa. Il rapporto di fedeltà o di infedeltà di Israele è sempre letto con termini nuziali o adulterini. Isaia, Osea, Ezechiele, i Salmi. ..ci danno una gamma vastissima di situazioni in cui il rapporto fedele o infedele di Israele nei confronti del Santo sono espressi con termini usati per dire la gioie e i drammi dell ' esperienza sponsale. Si pensi a Is 62,4-5: "Non si dirà più di te 'Abbandonata'. Non si dirà più della tua terra 'Desolazione '. Sì, tu sarai chiamata: 'Il mio desiderio è in te " e la tua terra: 'Sposata '. Sì, Adonai ti desidera, e la tua terra è sposata. Come il giovane sposa la vergine, i tuoi figli mi sposeranno. Del godimento dello sposo sulla sposa, il tuo Creatore godrà su di te ". Si pensi a Osea, per il quale il dramma della sua vita matrimoniale diventa il dramma del rapporto tra il Santo e il popolo ebreo (Os 2,4-10). Si pensi al libro di Ezechiele, dove esplode la gelosia del Santo nei confronti della Figlia di Sion accolta, allevata, amata, ma che poi si prostituisce con gli idoli pagani (Ez 16,1-58). Ma la fedeltà irrevocabile di Dio tornerà continuamente ad accogliere la Sposa e a purificarla (Os 2,16-25). Il Secondo Testamento, nella linea del Primo, ma, come accennavamo, con la radicalità raggiunta dall'incarnazione del Verbo divino, ritrova questi termini, queste immagini, questo valore della corporeità (Dio si fa corpo e ce ne fa dono). Non potrebbe essere diversamente, in quanto per l'ebreo Gesù di Nazaret, incarnazione di quella Parola, non può che vivere quella Parola che non conosce la dualistica e platonica divisione e contrapposizione tra anima e corpo. Gesù si definisce lui stesso "lo Sposo", attribuendosi il titolo che il Primo Testamento riserva al Santo (M t 9,15; 25,1; Gv 3,29; 2Cor 11,2; Ap 21,9). In Matteo (19,3-12) Gesù, a proposito del divorzio, rimanda alla lettura del "bere.5hit": solo in quella dimensione di accoglienza reciproca nell'alterità è possibile essere "una sola carne" non divisibile.
LA CORPOREITA' COME SOGGETTO Come abbiamo visto nella Bibbia, ma dobbiamo dire in tutte le religioni, il punto di partenza fondamentale è la dimensione sessuale, è il rapporto tra i sessi. Questo viene vissuto, nelle diverse culture, con due atteggiamenti di fondo che emergono in modo non univoco, appunto determinato dalle culture. Tali atteggiamenti possiamo definirli l'uno etico e l'altro estetico. Il primo atteggiamento nasce dal fatto che la sessualità, per la sua forza travolgente, sia a livello personale sia a quello sociale, fa paura poiche è imprevedibile anche nei suoi sviluppi e pertanto si tende a regolarla, certamente in modi culturalmente diversi. Per esempio, nelle culture che noi diciamo "primitive" la sessualità è regolamentata da riti ben definiti nelle età, e la procreazione ha molta importanza per la qual cosa si pongono i rapporti prematrimoniali come "verifica", con un atteggiamento di rapporto con il sacro, con il rito che accompagna i ritmi dell 'uomo e della donna. Il secondo atteggiamento, quello estetico, si pone invece in ascolto della capacità travolgente, "trasgressiva", di rottura con il già definito, e l'accoglie come segno del sacro e dell'esperienza religiosa. Ci troviamo allora nell'ambito della visione religiosa biblica che considera tutte le tensioni intrinseche alI' esperienza della sessualità come "icona" delle tensioni con il divino. La sessualità, nella sua capacità dirompente, diventa un simbolo profondamente religioso in quanto dice la prorompenza, l' eccedenza alI' ordinario, al regolamentato. Certamente ogni azione, ogni scelta, ogni comportamento richiede delle regole, ma contemporaneamente nella sessualità si percepisce una forza di rompente che è molto congeniale al sacro che rompe il cosmos, che apre alla vita, che è al di là e perciò è sempre trasgressivo (dal latino transgredi = andare oltre ). Trascendenza e trasgressività sono molto vicine come radice. Il sacro, tendenzialmente trasgressivo, trova nelle forme trasgressive della sessualità (che poi è fonte di vita) un simbolo autentico. E' questo l'aspetto estetico. Vedere come sono stati accostati i due atteggiamenti e constatare la difficoltà di armonizzarli diventa la riflessione di come nei momenti più intensi dell'esperienza religiosa vissuta dalla tradizione giudaico-cristiana l'aspetto più trasgressivo della sessualità è stato utilizzato come simbolo, per dire come ciò che trasgredisce il regolato conduce al fondamento di quanto è regolato. Il fondamento di ciò che è regolato (Gen 1 ), non è regolato: il Creatore (il Demiurgo = Elohym) non è sotto la legge, la trascende. La pulsione, la trasgressione può esserne il simbolo in quanto la sessualità dà la vita mentre la violenza (l'altro polo negativo della trasgressione) dà la morte. Se consideriamo il modo con il quale la "modernità" ha esasperato il primato del razionale e considerato il corporeo come realtà / oggetto, possiamo ora constatare come alcune fasce della "post-modernità" stiano rivalutando la corporeità come soggetto, cioè come realtà identificativa di se stessi. Sono risorse a cui dovremmo prestare attenzione critica e disponibile. E' come se Dio dicesse, servendosi della storia attuale: "Vi siete allontanati dalla visione armonica che vi avevo offerto come progetto per una umanità matura, ora vi do l'occasione di riacquistarla, creando una situazione culturale favorevole". Diversamente andrà aggravandosi sempre più l'idea che piacere e fede siano incompatibili, vi\lendoli come situazioni conflittuali: divertimento e chiesa considerati quali antitesi radicali finiranno con l' essere vissuti male come chiesa e come divertimento. Si pone qui il problema che sembra impensabile: coniugare preghiera e sessualità. I mistici medioevali per descrivere il rapporto con Dio, ispirandosi ai Profeti del Primo Testamento, hanno usato metafore esplicite della sfera sessuale, ispirandosi proprio al Cantico dei Cantici. Noi, più tardi, abbiamo estraniato, reso "dia-bolico", ciò che per se stesso, nel piano di Dio, è pensato come unito, "sim-bolico": Dio e Corpo. Solo in questa prospettiva acquista senso il sacramento del matrimonio: sesso e Dio, rapporto sessuale uomo-donna e Dio, così come l'Eucaristia è cibo-cena e Dio. Occorre riconiugare il senso profondo del rapporto Corpo-Dio, altrimenti viviamo il vero divorzio, il vero "peccato": la separazione di Dio dal Corpo. Nel rapporto dialogico con Dio vi sono sorprendenti analogie tra l'atteggiamento di preghiera e il rapporto di coppia, individuabili fondamentalmente in quattro punti. Il primo punto è quello che, probabilmente più degli altri, rende molto simile la Coppia e l' Alleanza, vale a dire il desiderio. Se stabiliamo il rapporto con gli altri esclusivamente in base alla razionalità, corriamo il rischio di ridurre l'altro/a alla nostra immagine dell'altro/a, al nostro concetto dell'altro/a. In tal caso solo così riteniamo possibile il rapporto, senza mezzi termini: o prendere o lasciare. Anzitutto nel rapporto con Dio può verificarsi questo comportamento: o riusciamo a "capirlo" razionalmente, facendone un oggetto di dibattito, riducendolo a un idolo, oppure non lo accettiamo, lo "buttiamo" dicendo che non ci interessa. Nel rapporto di coppia lo stesso atteggiamento (prendere o lasciare) si risolve in prepotenza, in prevaricazione, in esclusione del partner. Il desiderio, per sua natura, tende verso l'altro senza possederlo agendo in modo opposto alla razionalità: non è "o l'uno o l'altro" ma esclude la possibilità di cadere "nell'uno e nell'altro". Il desiderio fa tendere verso qualcosa o qualcuno altro da se evitando l'ateismo o l'esclusione del partner senza sequestrare l' altro/a nelle proprie categorie ed esigenze. La preghiera è il momento più delicato del rapporto con Dio che spesso può essere inteso come "io sono già in rapporto con Dio e in base a Lui organizzo la mia coscienza, faccio le mie scelte". Qual è il rischio sotteso? Quello che Dio sia dato per scontato. Possono passare gli anni e il "Dio dato per scontato" non interessa più, diventa un semplice presupposto ideologico. Però questo non può capitare nel momento della preghiera perche lì Dio mi sta di fronte e devo farci i conti, faccia a faccia. Egli è I' Altro e, nella preghiera, il cristiano non è più sicuro, non può più dare tutto per scontato. Se ci mettiamo di fronte a Dio, crollano tutti i nostri presupposti e dobbiamo fare i conti con qualcosa di non scontato. Anche il più dogmatico dei cristiani viene messo in crisi, viene cambiato dall'ascolto della Parola profetica. Dio, come dà a noi la libertà vuole anche conservare la propria e quindi non essere catturato dal nostro darlo per scontato. La stessa cosa si verifica nel rapporto di coppia: "dare per scontato" equivale a soffocare il rapporto fino a estinguerlo. Non è il matrimonio giuridico che garantisce la coppia ma sono i due "altri" che la costituiscono, che non sono ceduti in garanzia ma sono un dono gratuito. Alcuni studiosi stanno approfondendo questa dimensione del dono e dicono che probabilmente il primo rapporto sociale non è nato dall'istituzione ma dal dono che non crea nessuna coercizione istituzionale e non obbliga l'altro a contraccambiare. Questi, però, si sente in dovere di contraccambiare pur non essendo obbligato da nessuna legge. E nasce un rapporto intersoggettivo che previene ogni rapporto istituzionale. Il rapporto con Dio nella liturgia, ma soprattutto nella preghiera, viaggia su questo binario del dono: è il dono gratuito (kayre) di Dio che fa la Chiesa e non la Chiesa che fa Dio! La stessa cosa vale per il matrimonio: è l'amore donato tra i due che fa il matrimonio e non viceversa. Il secondo punto da evidenziare è il completamento, che non va inteso come ,fuj'ione. Nel rapporto con Dio come in quello di Coppia è importantissima la nostalgia delle origini o del futuro, molto simile al desiderio. Si tratta della nostalgia di un rapporto profondo, unitario e contemporaneamente rispettoso; nostalgia di un rapporto armonico; nostalgia del grande desiderio di essere completati e completare qualcuno. Cerchiamo un rapporto che mantenga la nostra identità e contemporaneamente completi la nostra e quella dell'altro/a. Il completamento escatologico della nostra fede si esprime nel grande desiderio di completare e essere completati da Dio e nella consapevolezza dell'impossibilità di realizzarlo totalmente subito. Pertanto la fede ci proietta in un futuro di completamento: una nostalgia delle origini (il progetto creazionale) proiettata nel momento del compimento escatologico (Ap 17, 17). Qualcosa di analogo si verifica anche nei rapporti di amicizia, di parentela, di coppia: l' altro è colui che mi completa e che completo. Qui nasce il rischio della competizione che è l'opposto del completamento, cioè la tentazione di dimostrare qualcosa alI 'altro, dimostrare soprattutto che si vale qualcosa. Nell'amore, se si comincia a dover dimostrare qualcosa, si incomincia a non amare più: l'amore non è dimostrare qualcosa, ma mostrare all'altro se stesso. Mostrare è molto vicino a "rivelare". Dio non dimostra nulla. Non è venuto a dimostrare la sua esistenza ma a mostrare il suo volto di misericordia. Mentre il teologo cerca, o cercava di dimostrare l'esistenza di Dio, 1 'uomo di preghiera mostra se stesso a Dio e cerca di ascoltare il mostrarsi di Dio. La preghiera è un mostrarsi reciproco, uno stare uno di fronte all'altro (Gen 2,18) e in tal modo rendere visibile (rivelare) il mistero. La cosa più preziosa che possiamo offrire all'altro è mostrare semplicemente noi stessi. In questo senso c'è completamento e non una "fusione" chimica di elementi. Il terzo punto è il gioco, cioè la dimensione ludica dell'essere umano. A differenza delle nostre società post-industriali che non sopportano il non-produttivo, le società che noi definiamo "primitive" considerano il non-produttivo quale valore sacro. D'altra parte il non-produttivo ci svela mondi straordinari: la fantasia, la fiaba, il mito; ci dischiude altri mondi. Oggi anche i fisici arrivano adire che non si dovrebbe parlare di uni-verso, ma di pluri-versi, fino a ipotizzare altre dimensionalità. Tutto va verso il pluralismo fisico, sociale, culturale. Non siamo costretti solo in una dimensione (la "tentazione di Babele" in Gn 11,1-9): tutto questo si può dire con la parola gioco. Giocare è creare e sappiamo che il gioco è una cosa molto seria e non pesante. La creazione è un grande gioco di Dio creatore (Sap 8,22-31). Creare è fare un gioco: non c'era nessuna ragione che esigesse l'esistenza dell'universo ma Dio si è messo a giocare e non è preoccupato di creare cose inutili. L 'utile è necessario, ma ci deve essere il momento del gioco, cioè dell'inutile. Maritain (L 'Umanesimo integrale) dice che l'uomo è veramente felice quando si scopre "fine" e non "mezzo" della creazione. Il fine di tutto è Dio che fondamentalmente è l'Inutile, colui che è la Bellezza solo perche c'è. Il rapporto coniugale è fecondo non quando si propone di produrre, ma anzitutto quando è inutile verso il partner e mantiene questo atteggiamento verso i figli. Essi valgono non in quanto funzionali ai nostri bisogni, ma per se stessi. Il gioco preserva dalla noia e nella coppia rivela l'uno all'altra e l'uno per l'altra. Adamo dice a Eva: "con te sto bene, non perche mi servi, ma perche ci sei. Tu sei la mia benedizione. Nel femminile, infatti, c'è qualcosa di molto importante: l'ospitalità, l'accoglienza, il rapporto di gioco con l'altro. Non c'è il rapporto di competizione, proprio del maschile. Per questo si chiede al maschio di avere una componente femminile di accoglienza e quindi di gioco. Infatti è necessario giocare con la vita oltre che produrre. Nella procreazione il maschio "interviene" per un momento mentre la femmina si impegna per nove mesi: un rapporto molto diverso. Mentre l'uno può essere definito "economico" l'altro è uno "stare con", un "avere tempo". Un padre e una madre che non smettono di giocare "stando-con", non dimenticano di essere solo genitori, ma anche figli. Se dimenticano la loro "figliolanza" rischiano di sentirsi responsabili di tutto pensando che tutto dipenda da loro, rendendo i rapporti invivibili. Siamo cristiani perche siamo figli e abbiamo un Padre, poi diventiamo discepoli del Cristo. Egli ci è maestro in quanto è figlio e ci ammaestra con il suo modo di esserlo: il suo essere figlio è magistero ed è il dono del Padre che nutre la nostra consapevolezza di figli. Il quarto punto è il piacere. L 'incontro dell'altro non sta solo nell'accorgersi dell'altro ma anche nel muoversi verso l'altro. La conoscenza dell'altro dipende da come ci si muove verso di lui, anche fisicamente oltre che mentalmente. Questo è un principio "esistenziale" della tradizione ebraica: "noi faremo ed ascolteremo": noi obbediamo alle leggi di Dio perche ci ha liberati. Egli è il Dio che agisce, che si coinvolge con il suo popolo, che "viene" e libera. Quale è la fonte del movimento, dell"'andare verso"? Il piacere, lo stimolo che muove verso l' altro tentando di fare con l' altro un ' esperienza di piacere che è la comunione profondissima e strettissima con l'altro al punto di perdere la nozione del tempo, massima esperienza possibile sulla terra. L' eternità è infatti l' attimo eterno di un rapporto di totale comunione tra Dio e l' Adam. Infatti l'esperienza più simile all'eternità è la percezione psicologica del tempo che abbiamo del momento del sommo piacere. Possiamo affermare che il piacere nel suo apice è l'udienza data all'eternità nel tempo. Parliamo certo del piacere intenso, profondo, comunionale. Il piacere rivela alla coppia la possibilità che essa è più del tempo che vive, e di ciò ha profondamente bisogno in quanto, inserita nel tempo e nella storia, deve percepire la possibilità di andare oltre il tempo e la storia: anticipazione di paradiso (paràdosis = consegna). Il piacere è vicinissimo al gioco perche vissuto veramente in due: momento di eternità condiviso e non solipsistico: è rapporto stretto con l'altro. Una coppia può dimostrare la possibilità di raggiungere insieme la quasi eternità, diventando così sacerdote e profeta, segno sacramentale di un eterno vissuto in comunione con Dio, con tutta la comunità, con tutta la creazione (Rom 8), un eterno vissuto a livello di alterità. Così la coppia celebra la sua continua e rinnovata Alleanza/Riconciliazione correggendo l'aspetto negativo del piacere e mantenendolo nel suo valore più reale, profondo, aperto all'altro quale simbolo massimo (mèga mysterion = Ef5,32). Salvatore Frigerio |
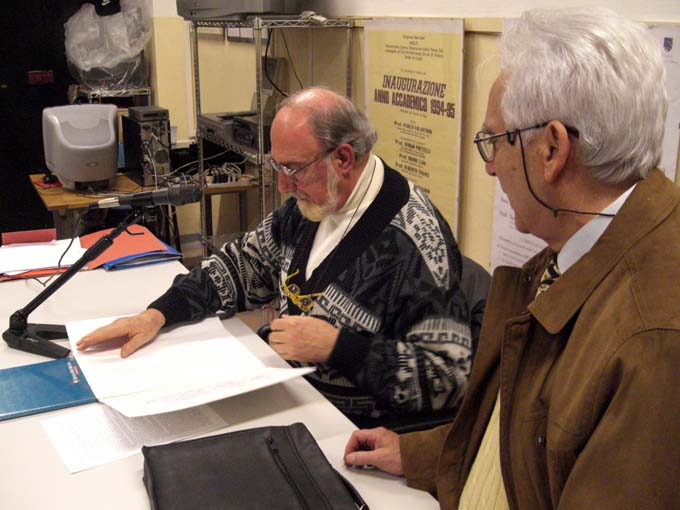 Scrittura
ogni persona, scegliendo la vita (Dt 30,19) la ottiene vivendo le leggi
del Creatore della vita (Lv 18,5). Chi osserva i comandi divini
(coagulati nei 613 precetti .frutto della Torah) realizza
simultaneamente la volontà di Dio e se stesso, in quanto opera di Dio
("vivrai/morrai " in Gn 2,15- 16). La persona è un valore assoluto,
nella sua complessità che è fatta anche di dialettica tra corpo
terrestre (adàm: venuto dall 'adamà) e respiro divino, tra maschile e
femminile, dualità espressa subito dalla prima lettera della Bibbia (bet).
Dialettica insita nello stesso Creatore (Elohim). L' esistenza è un
confronto continuo tra le diversità, è proprio il rapporto dialogico che
di schiude la vita: "l 'adam solo non è cosa buona": non è la vita. L
'unione sponsale è interpretata dall'ebraismo come l'adempimento del
precetto divino che invita gli esseri viventi a unirsi e a essere
fecondi ("l 'uomo aderisce alla sua donna ed essi sono una sola carne "-
Gen 2,23; " Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra,
percorretela "- Gen 1,28). Tuttavia la procreazione non è I 'unico
obbiettivo dell 'unione sponsale. La categoria della fecondità assume
anche dei caratteri simbolici, nell ' ebraismo, diventando sinonimo di
ricchezza dei sensi. Nell'urgente sensualità del Cantico dei Cantici, I'eros
è pienamente protagonista, riflettendosi, rivelandosi nelle incalzanti
metafore sessuali con cui la donna (il Cantico è ode prettamente
femminile) e I 'uomo descrivono la bellezza della sessualità. La
corporeità è celebrata senza filtri (noi ce li abbiamo messi...)
nell'intreccio pur altamente poetico del Cantico, divenendo un valore in
se, a prescindere da ogni funzionalismo biologico, e assumendo quasi le
caratteristiche di un linguaggio palpitante e, insieme, ispirato.
Sostiene Lévinas che la dimensione erotica è in grado di originare,
attraverso la fecondità, il tempo e quindi di dischiuderc il futuro.
Scrittura
ogni persona, scegliendo la vita (Dt 30,19) la ottiene vivendo le leggi
del Creatore della vita (Lv 18,5). Chi osserva i comandi divini
(coagulati nei 613 precetti .frutto della Torah) realizza
simultaneamente la volontà di Dio e se stesso, in quanto opera di Dio
("vivrai/morrai " in Gn 2,15- 16). La persona è un valore assoluto,
nella sua complessità che è fatta anche di dialettica tra corpo
terrestre (adàm: venuto dall 'adamà) e respiro divino, tra maschile e
femminile, dualità espressa subito dalla prima lettera della Bibbia (bet).
Dialettica insita nello stesso Creatore (Elohim). L' esistenza è un
confronto continuo tra le diversità, è proprio il rapporto dialogico che
di schiude la vita: "l 'adam solo non è cosa buona": non è la vita. L
'unione sponsale è interpretata dall'ebraismo come l'adempimento del
precetto divino che invita gli esseri viventi a unirsi e a essere
fecondi ("l 'uomo aderisce alla sua donna ed essi sono una sola carne "-
Gen 2,23; " Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra,
percorretela "- Gen 1,28). Tuttavia la procreazione non è I 'unico
obbiettivo dell 'unione sponsale. La categoria della fecondità assume
anche dei caratteri simbolici, nell ' ebraismo, diventando sinonimo di
ricchezza dei sensi. Nell'urgente sensualità del Cantico dei Cantici, I'eros
è pienamente protagonista, riflettendosi, rivelandosi nelle incalzanti
metafore sessuali con cui la donna (il Cantico è ode prettamente
femminile) e I 'uomo descrivono la bellezza della sessualità. La
corporeità è celebrata senza filtri (noi ce li abbiamo messi...)
nell'intreccio pur altamente poetico del Cantico, divenendo un valore in
se, a prescindere da ogni funzionalismo biologico, e assumendo quasi le
caratteristiche di un linguaggio palpitante e, insieme, ispirato.
Sostiene Lévinas che la dimensione erotica è in grado di originare,
attraverso la fecondità, il tempo e quindi di dischiuderc il futuro.